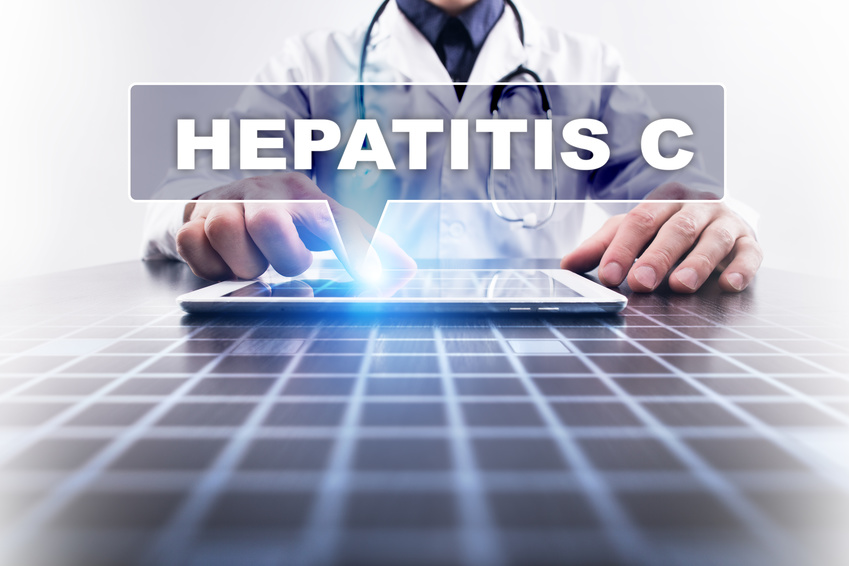Entro il 2030 l’Organizzazione mondiale della sanità chiede di eradicare l’epatite C, un’infezione del fegato che colpisce oltre 70 milioni di individui in tutto il mondo. Una malattia asintomatica, che si manifesta quando è in fase molto avanzata e può sfociare in cirrosi, tumore al fegato e provocare altre complicazioni a livello epatico. Grazie ai nuovi antivirali ad azione diretta si può curare con un’efficacia del 95%. Ma il problema di questa infezione è trovarla. Oggi in Italia l’epatite C interessa soprattutto una parte di popolazione che è difficile da intercettare: dai consumatori di sostanze per via endovenosa alla popolazione carceraria, passando per tutti quegli individui che non frequentano centri di recupero ma portano avanti comportamenti a rischio. Il Governo ha stanziato oltre 70 milioni per intensificare la campagna di screening, ma senza un percorso di cura adeguato, si rischia di non centrare il prezioso obbiettivo del 2030.
Come si scopre l’infezione
Le persone scoprono l’infezione in modo casuale, magari dopo aver fatto analisi del sangue che documentano l’alterazione degli indici di funzionalità epatica. «Circa Il 15% di chi contrae Hcv guarisce in modo spontaneo — spiega il professor Claudio Mastroianni, Direttore Uoc Malattie Infettive del Policlinico Umberto I di Roma e presidente eletto della Simit, Società Italiana della Malattie Infettive e Tropicali — mentre nell’85% dei casi l’epatite diventa cronica. Di questi, circa il 15-20% dei casi va incontro a cirrosi epatica, di cui il 2-3 % all’anno può sviluppare tumore al fegato». L’epatite C si trasmette attraverso il contatto con sangue e mucose, rapporti sessuali a rischio, scambio di aghi o siringhe, esecuzione di tatuaggi o piercing senza l’applicazione di corrette norme igieniche, esposizione accidentale al sangue infetto da parte di operatori sanitari.
Quali sono le cure disponibili
Non esistono un vaccino o una profilassi specifica. Gli unici strumenti preventivi sono costituiti dalla riduzione dei fattori e dei comportamenti a rischio. Prima dell’arrivo degli antivirali ad azione diretta, per curare l’epatite C si usavano terapie con interferone pegilato in combinazione con ribavirina, che avevano però un’efficacia limitata, intorno al 50%. I nuovi antivirali hanno un’efficacia del 95% e sono presenti in Italia dal 2014. Trattandosi di terapie curative dell’infezione, l’uso di questi farmaci è diminuito nel tempo: come riportano recenti analisi svolte da Iqvia, provider di tecnologie e informazioni in ambito sanitario, negli ultimi 5 anni si è assistito a una diminuzione del 21% delle dosi vendute. La decrescita ci dice che si stanno curando tutte le persone diagnosticate quindi, ogni anno, si usano meno farmaci a mano a mano che si copre la popolazione interessata dall’infezione.
Quanti sono i portatori sani in Italia
Questo non significa che la malattia stia sparendo ma che si stanno solo trattando le persone diagnosticabili. Che sono solo una parte di quelle esistenti. Secondo i Registri Aifa per il monitoraggio dei farmaci anti-Hcv, i pazienti trattati con i farmaci innovativi sono circa 227.789 (al 27 settembre 2021). Ma secondo diverse stime le persone che hanno epatite C senza saperlo potrebbero essere circa 400 mila. Esistono delle popolazioni che sono rimaste ai margini e che possono rappresentare importanti serbatoi del virus, come detenuti, tossicodipendenti e migranti. Per questo i penitenziari e i SerD sono punti di riferimento per intercettare questi soggetti. E con l’arrivo della pandemia è probabile che la stima del sommerso sia da rivedere al rialzo. Un’indagine svolta nel 2020 dall’Associazione italiana per lo studio del Fegato (Aisf) ha evidenziato infatti una drastica riduzione delle attività ambulatoriali di epatologia e dei trattamenti antivirali.
Come sono tracciati i potenziali contagiati
In Italia la strategia per tracciare i potenziali contagiati da Hcv si basa su uno screening graduato, che identifica le popolazioni giovani (nati tra il 1969 e il 1989) a rischio di trasmissione e si estende anche alle popolazioni chiave già menzionate (detenuti, soggetti che frequentano i SerD, persone con comportamenti a rischio). «Le persone a rischio non sono solo quelle che frequentano questi centri — spiega Marco Riglietta, vice direttore del Comitato scientifico di FederSerD, Federazione Italiana degli Operatori dei Dipartimenti e dei Servizi delle Dipendenze — ma tutti i consumatori di sostanze stupefacenti che usano aghi o inalano droghe. Al SerD è difficile fare i test perché tanti non si presentano all’appuntamento. Ma il punto non è tanto lo screening, ma tutta la gestione del paziente. Occorrono case manager che seguano la persona, da quando le si dà l’appuntamento, a quando esegue il test e riceve, se positivo, la terapia. All’interno del progetto HAND (Hepatitis in Addiction Network Delivery, un progetto promosso da diverse associazioni nell’ambito dell’infettivologia e delle dipendenze: Simit, FederSerd, Sipad, Sidt, ndr) abbiamo realizzato una campagna di screening durata un mese: quando i pazienti venivano al SerD per ritirare i farmaci, offrivamo loro l’opportunità di fare il test. Così siamo riusciti a intercettarli».
La situazione nelle carceri
A differenza dei SerD, nelle carceri la situazione pare essere più sotto controllo: «In Lombardia — specifica Roberto Ranieri, infettivologo e responsabile per la sanità penitenziaria della regione — il test Hcv viene fatto nel 60-70% della popolazione carceraria. Il punto però è che non tutti i medici possono prescrivere i farmaci antivirali. Questo rischia di creare colli di bottiglia con numeri di richieste elevati rispetto ai medici che possono fare le prescrizioni. E ostacola il linkage to care, il percorso che porta il paziente a ricevere il farmaco». Uno dei modi più efficaci per diffondere gli screening potrebbe essere quello di affiancarli ai test per il Covid-19, oppure somministrarli in sede di vaccinazione anti-Covid, o in qualsiasi altra occasione in cui un paziente esegua un esame o una visita in ospedale.
La sostenibilità degli screening
Gli screening, fatti nel modo giusto, potrebbero evitare costi notevoli per il Servizio sanitario nazionale: «Secondo alcune analisi —spiega Francesco Mennini, docente di Economia sanitaria e Microeconomia presso l’Università Tor Vergata di Roma e la Kingston University di Londra e presidente Sihta, Società Italiana di Health Technology Assessment — per mille pazienti diagnosticati e trattati, in 20 anni si andrebbero a prevenire oltre 600 eventi clinici infausti, a partire da episodi di cancro del fegato, con un risparmio per il Ssn di oltre 65 milioni di euro». E per quanto riguarda l’uso dei farmaci antivirali ad azione diretta, il team di Mennini ha stimato che gli investimenti su queste cure si potrebbero recuperare in soli cinque anni e mezzo.
Fonte: Corriere.it