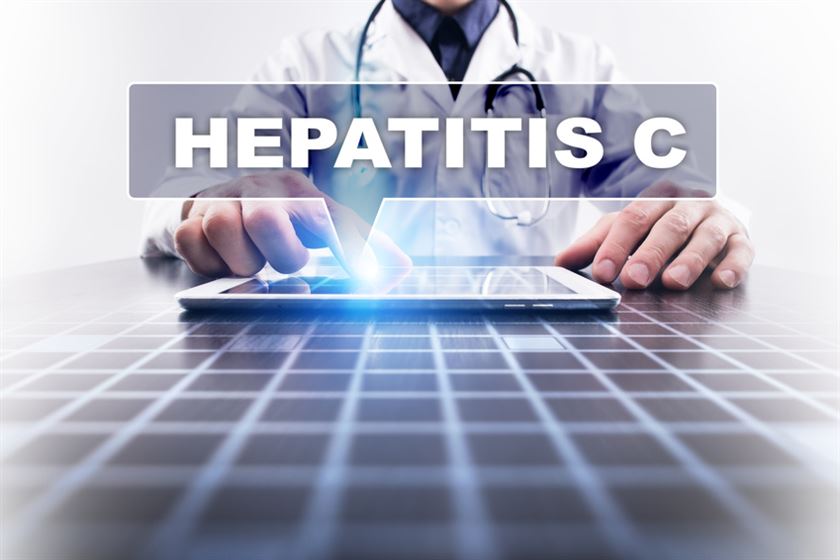L’epatite C da qualche anno ha trovato nei farmaci ad azione antivirale diretta un grande alleato per avvicinarci all’obiettivo Oms dell’eliminazione del virus entro il 2030. Tuttavia, in Italia la strada da fare è ancora molta e passa anche attraverso l’estensione dello screening ai nati tra il 1948 e il 1968
Fino al 2013 era una malattia priva di una cura efficace: i farmaci disponibili funzionavano in meno del 50% dei casi, a fronte di pesanti effetti collaterali. L’epatite C è stata una patologia che per decenni ha portato con sé uno stigma: poiché si tratta di un’infezione che si trasmette per via ematica, sono maggiormente a rischio le popolazioni che fanno uso di sostanze, i carcerati e gli omosessuali. In realtà l’infezione può essere contratta anche dal sangue infetto di una trasfusione o da strumenti non ben sterilizzati, in sala operatoria o dal dentista. Quest’ultima, peraltro, è stata la via di maggior diffusione della trasmissione dell’infezione in Italia nel passato.
L’infezione cronica da Hcv dura per un periodo lungo anche fino a trent’anni senza mostrare sintomi e quindi rimane spesso non diagnosticata.
Nel 2013, c’è stata la grande svolta. L’era dei farmaci ad azione antivirale diretta (Daa) ha comportato una vera rivoluzione nella cura dell’epatite C: due o tre mesi di trattamento permettono, in oltre il 98% dei casi, di eliminare il virus e quindi portano la maggioranza dei pazienti alla guarigione della malattia Hcv correlata.
Dal 2015 la terapia con i Daa è stata possibile anche in Italia, facendo tirare un sospiro di sollievo alle persone con la malattia ma ponendo anche un grande problema etico: poiché la terapia era costosissima, non tutti avrebbero potuto averla subito. Per la prima volta nel nostro Paese si è dunque derogato all’universalità del Servizio sanitario nazionale, decidendo di trattare per primi i casi più gravi. Sfruttando la lenta progressione della malattia, si è dunque stilata una sorta di “lista d’attesa”. Questo sistema ha alimentato veri e propri “viaggi della speranza” in Paesi come l’India e l’Egitto per riuscire a conquistare le dosi di farmaco necessarie.
Nel marzo 2017, poi, il Ministero della Salute ha ampliato i criteri di accesso alla terapia, permettendo di curarsi a tutti coloro che avevano ricevuto una diagnosi di epatite C.
Tra il 2015 e il 2022 si calcola che nel nostro Paese siano state trattate oltre 244.000 persone e dall’anno scorso il Ministero ha avviato uno screening nazionale per tutti i nati tra il 1969 e il 1989.
L’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) ha infatti inserito l’eliminazione dell’infezione da Hcv entro il 2030, ma quanto è realizzabile questo obiettivo?
Il sommerso
“Dipende da che cosa prendiamo in considerazione – premette Loreta Kondili, gastroenterologa del Centro Nazionale per la Salute Globale dell’Iss –: con l’arrivo dei nuovi farmaci ad azione diretta antivirale l’Italia è il primo Paese europeo per numero di pazienti trattati. Abbiamo dunque ridotto in maniera significativa l’impatto della malattia: i farmaci infatti eliminano il virus con un’efficacia superiore al 98%”.
A questi ritmi, il nostro Paese, secondo l’esperta, dovrebbe raggiungere l’obiettivo della riduzione della mortalità Hcv correlata di oltre il 65% già entro il biennio 2023-2025.
Tuttavia, gli obiettivi di eliminazione prevedono anche la riduzione di almeno il 90% della prevalenza rispetto al 2015 e dell’80% dell’incidenza (quindi dei nuovi casi di infezione). Inoltre, entro il 2030 almeno l’80% dei casi diagnosticati dovranno essere trattati.
“Abbiamo registrato un drastico calo del numero dei trattamenti tra il 2018 e il 2022 – rende noto Kondili –. All’epoca curavamo circa 56.000 persone all’anno, oggi arriviamo a fatica ai 14.000”.
Potrebbe sembrare una buona notizia: poiché chi viene trattato guarisce, significa che si stanno esaurendo le persone diagnosticate. “Il problema è che abbiamo un sommerso stimato di circa 300.000 persone asintomatiche, che quindi non sanno di avere il virus. Da qui l’importanza dello screening, unico strumento che permette di mappare il numero di malati”.
A questi se ne devono aggiungere altri 100.000 circa, che hanno un danno severo al fegato e a cui non è stata diagnosticata l’infezione da Hcv, oppure trascurano le cure.
Questi dati, tuttavia, non sono una fotografia dell’esistente, ma il risultato di una simulazione effettuata grazie a studi matematici di modelling che si basano su dati di storia naturale, di trattamento ed epidemiologici degli anni passati in Italia poi attualizzati.
L’importanza dello screening
L’Italia è uno dei pochi Paesi al mondo ad aver stanziato un fondo ad hoc per lo screening dell’epatite C.
Dal 1° gennaio 2022 i nati tra il 1969 e il 1989 possono sottoporsi al prelievo necessario per diagnosticare l’infezione e, in caso di esito positivo, eliminare il virus e curare quindi la malattia da esso causata. Purtroppo, a oltre 12 mesi di distanza, questa non è ancora una possibilità per tutti: alcune Regioni, infatti, non hanno ancora aderito al programma. A fine 2022 si erano attivate solo in 11.
L’altra criticità riguarda la mancanza di risorse per le campagne di comunicazione: “I 71,5 milioni di euro stanziati coprono soltanto i test e non la sensibilizzazione della popolazione e del personale sanitario – afferma Kondili –. Per questo il Ministero ha prorogato fino a fine 2023 lo screening”.
Nonostante sia passato un anno dall’inizio dei test, ad oggi non è noto quante siano le persone che vi si sono sottoposte e con che esiti: “All’Istituto superiore di Sanità abbiamo dati parziali e non tutte le Regioni hanno già trasmesso i dati”, spiega Kondili.
Alla platea potenzialmente interessata di 17 milioni di persone si sommano i soggetti attualmente seguiti dai SerD e i carcerati. L’ambizioso obiettivo è sottoporre al test in questi due anni almeno il 70% della popolazione target, considerata quella a maggior rischio di trasmissione dell’infezione.
Il prossimo passo, secondo l’esperta, sarebbe estendere lo screening, entro l’anno 2023, anche ai nati tra il 1948 e il 1968, persone che hanno una probabilità maggiore di sviluppare danni progressivi del fegato qualora dovessero rimanere non diagnosticati.
Nei primi anni Duemila nel Sud Italia una persona su tre aveva l’Hcv
“Dati relativi ai primi anni 2000 ci dicono che nel Sud Italia una persona su tre aveva l’Hcv: molti sono stati già trattati in questi anni, ma rimane ancora tanto da fare per portare allo scoperto questo sommerso e far arrivare tutte queste persone alle cure per eliminare l’infezione e fermare la progressione delle malattie che causano l’epatite C”, espone l’esperta.
Oltre a migliorare la qualità di vita e la prognosi dei pazienti, questa operazione potrebbe generare anche un risparmio per il Servizio sanitario nazionale: “Abbiamo calcolato che l’implementazione dello screening alle persone nate tra 1948-1968 permetterebbe di evitare oltre 5.000 pazienti con cirrosi e con cancro del fegato nei prossimi 10 anni e oltre 11.000 morti Hcv-correlate. Questo investimento immediato porterebbe quindi a un risparmio di 62 milioni di euro in 10 anni”.
Come avviene il test
Le modalità per lo screening possono differire in base alla popolazione che vi si sottopone. I nati tra il 1969 e il 1989 dovranno sottoporsi a un test sierologico, con la ricerca di anticorpi anti Hcv, e al reflex testing (se il test per Hcv Ab risulta positivo, il laboratorio eseguirà immediatamente, sullo stesso campione, la ricerca dell’Hcv Rna o dell’antigene Hcv-Hcv Ag), oppure attraverso un test capillare rapido e conferma successiva del Hcv Rna nel caso di risultato positivo.
Per le persone che sono in carico ai SerD e per i carcerati invece la preferenza ricade sul test rapido, eseguibile su sangue intero con prelievo capillare, o con l’Hcv Ab o direttamente con l’Hcv Rna misurati attraverso un Poc (Point of care). La scelta della tipologia di esame avverrà sulla base della valutazione del contesto epidemiologico locale.
L’esito dell’esame sarà restituito previo colloquio con il personale sanitario che ha prescritto il test: in questa sede saranno fornite le informazioni necessarie per l’eventuale trattamento e per le misure di prevenzione, identificando le strutture di presa in carico.
In caso di Hcv-Rna negativo non sarà effettuato ulteriore accertamento nella popolazione che non presenta fattori di rischio, invece per la popolazione che fa uso di sostanze o per i carcerati o altre popolazioni chiave il test va ripetuto ogni anno in quanto esiste la possibilità di una nuova infezione o reinfezione. Se l’Hcv-Rna dovesse risultare positivo, il paziente sarà indirizzato verso un centro specializzato per proseguire gli accertamenti diagnostici con la stadiazione della patologia e iniziare immediatamente la terapia.
Per ulteriori informazioni i cittadini possono far riferimento alla propria Regione.
Fonte: trendsanita.it